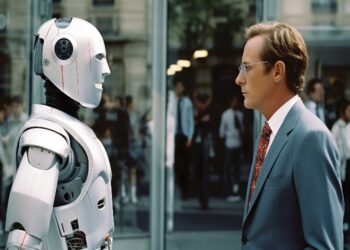Il fenomeno del diversity washing consiste nella creazione da parte delle aziende di campagne advertising e attività a supporto dei temi legati alla diversity and inclusion senza che vi sia un reale interesse o rispetto per tali argomenti, e rischia di diventare il nuovo greenwashing.
La decisione di indagare questo argomento nasce dalla volontà di comprendere se sia possibile catalogare il diversity washing come una pratica scorretta, idonea a falsare il giudizio dei consumatori e a rompere l’equilibrio della libertà e correttezza della concorrenza. Per questo motivo, l’analisi del fenomeno dal punto di vista giuridico è volta non solo a tentare di descrivere e circoscrivere tale pratica rispetto alla moltitudine delle tecniche di marketing impiegate al giorno d’oggi, ma anche a compiere un ulteriore passo in avanti e comprendere se sia possibile avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla normativa italiana vigente in materia di greenwashing per condannare questa tipologia di pratiche.
La disciplina giuridica al momento non cita chiaramente il diversity washing tra gli atti illeciti; perciò, si è cercato di applicare i principi base della normativa pubblicitaria e concorrenziale per capire se vi siano i presupposti per formulare un’ipotesi di sanzione da parte degli organi giudiziari e amministrativi.
Il punto di partenza per l’applicazione dei principi normativi alla prassi di diversity washing è il caso di greenwashing che ha coinvolto le aziende italiane Miko e Alcantara, e che ha portato all’ordinanza cautelare n.712 del Tribunale di Gorizia del 25 novembre 2021. Le norme richiamate dall’ordinanza in materia di pubblicità ingannevole e illecito anticoncorrenziale – secondo quanto previsto nel Codice di Autodisciplina Pubblicitaria dello IAP e il Codice Civile – sono state applicate ad un caso di diversity washing avvenuto recentemente negli Stati Uniti. Si tratta di un progetto di ricerca chiamato Pride Accountability and Fake Allies, il quale si è impegnato nello smascherare le aziende sponsor della manifestazione Pride in molte città americane che, allo stesso tempo, finanziavano con ingenti somme di denaro i politici che promuovevano disegni di legge discriminatori nei confronti della comunità LGBT.
Si può ritenere che al momento sia difficile sanzionare casi di diversity washing attraverso la normativa italiana, che si presenta ancora di carattere ampio, generale e in ritardo rispetto alla nascita ed evoluzione di nuove pratiche scorrette. Sfortunatamente, la produzione legislativa segue un percorso meno rapido rispetto alle nuove strategie di business ed è spesso in rincorsa, arrivando solo in seguito all’apparizione delle controversie che necessitano di copertura giuridica. Tuttavia, il fatto che la disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale si presti a diverse interpretazioni e possa potenzialmente regolare casistiche eterogenee, permette un margine maggiore di applicazione della legge. È proprio grazie a questa caratteristica peculiare che è stato possibile teorizzare la regolamentazione della prassi del diversity washing.
L’attuale lacuna normativa richiede uno sforzo maggiore da parte degli enti di monitoraggio e ricerca sul tema della diversity and inclusion in Italia. Uno di questi è la fondazione Diversity, che da anni si impegna a diffondere l’inclusione e la rappresentazione di tutte le diversità in tre ambiti di intervento: l’informazione, i media e il business. Grazie ad un’intervista con Gabriella Crafa, vicepresidente di Diversity, è emerso che la sensibilità dei consumatori nei confronti della diversity and inclusion è in crescita, ma non solo: anche le aziende stanno muovendo i primi passi, iniziando un percorso di diversity transformation che va a rimodellare i processi, le logiche e le relazioni aziendali. Diversity è al fianco delle aziende in questo processo promuovendo un lento ma radicale cambiamento che mette al centro l’ascolto e la comprensione delle persone. Un’azienda capace di integrare la diversity and inclusion in maniera efficace ottiene vantaggi importantissimi, soprattutto a livello di net promoter score, ovvero il passaparola.
La diversity transformation genera quindi fiducia, e il brand viene percepito come autentico. Purtroppo, anche in Italia vi è il rischio di imbattersi in casi di diversity washing, seppur non riconosciuti, come ha spiegato Gabriella Crafa. Il contesto è ancora immaturo, la normativa non è sufficiente e le certificazioni e gli strumenti di misurazione della diversity and inclusion che vengono utilizzati non sono efficaci. Trattandosi di misure perlopiù quantitative e non obbligatorie per legge, spesso non vengono implementate o non sono capaci di dare la spinta necessaria al cambiamento.
In Italia, realtà come Diversity possono ricoprire un ruolo fondamentale grazie al lavoro di ricerca sul campo e affiancamento delle aziende durante il processo di diversity transformation, per assicurare una corretta applicazione dei principi della diversity and inclusion. Ciò è ancora più importante dal momento che la legge non si è ancora espressa sul diversity washing, rendendo difficile l’individuazione di queste pratiche illecite e la successiva sanzione. Per limitare il fenomeno e disincentivare le aziende che lo mettono in atto occorrono due fattori, entrambi fondamentali: un intervento legislativo mirato, che riconosca il diversity washing e le sue sfumature (rainbow washing, pinkwashing) e preveda un sistema di sanzioni; uno strumento di misurazione della diversity and inclusion aziendale, capace di valutare tutte le sue sette aree in modo olistico e con un’ottica sia interna che esterna.