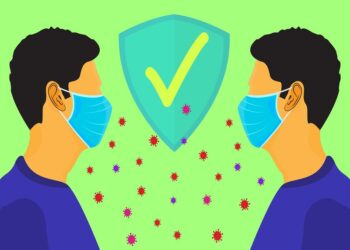1) Lei ha scritto di recente un libro dal titolo “La scuola al tempo del Covid. Tra spazio di esperienza e orizzonti d’attesa” (Ed. Studium, Roma 2020). Ce ne riassume i contenuti fondamentali?
È un libro sulle numerose occasioni fatte perdere alla scuola e ai giovani nell’ultimo anno. O, se preferisce, un libro sui peccati gravi di natura formativa commessi da una sé dicente “classe dirigente” ministerial-sindacal-politica che, però, avendo perduto il senso del peccato, non è più nemmeno in grado di confessarli, e quindi di promettere di non ripeterli più, riparando al contempo ai danni sempre maggiori prodotti. Al punto di aver approvato una legge (decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120) che solleva i “dirigenti” governativi dal dover rispondere di eventuali danni prodotti per “colpa grave” nella loro azione. Questa “classe dirigente” è talmente ostaggio dei bias del suo modo di pensare e di agire da ritenere, come donna Prassede, che il suo sia l’unico e migliore modo di pensare, nel nostro caso al mondo della scuola. Al punto da non riuscire nemmeno ad ascoltare e capire il senso di chi ne ha e ne propone un altro. Bisognerebbe essere perfetti come Gesù Cristo per poter dire “Padre, perdona loro perché non sanno quello che hanno fatto, fanno e purtroppo continueranno a fare”. Non essendo perfetto, ho scritto perciò una mi pare argomentata requisitoria contro ciò che reputo furto di futuro e di qualità degli apprendimenti perpetrato da questa “classe dirigente” poco responsabile nei confronti delle giovani generazioni. Culpa lata dolo aequiparatur, dicevano i Romani. Ecco perché, avendo l’attuale classe dirigente divelto questo sanissimo principio, non solo tutto, nella scuola, non tornerà più come prima (che non era già in ogni caso accettabile), ma sarà di gran lunga peggio di prima, con un’ulteriore accelerazione delle malattie del sistema scolastico conclamate ben prima dello scoppio di Covi-19. Nonostante i miliardi spesi a debito e la caramellosa e infida retorica sulla pretesa centralità della scuola e dell’istruzione nello sviluppo del paese.
2) Da marzo 2020 in poi l’Italia è stata la nazione che ha tenuto maggiormente chiuse le scuole. Colpa del governo, ma anche delle regioni. Che cosa andava fatto e non è stato fatto?
Bisognava anzitutto prendere sul serio l’emergenza proclamata il 31 gennaio 2020, e non usarla soltanto a fini strumentali di potere. A parte le misure di prevenzione sanitaria e soprattutto di presidio sanitario come termoscanner, medici scolastici, tamponi, tamponi, tamponi per aggredire immediatamente i possibili focolai (cose ancora non fatte dopo un anno!); a parte gli interventi anch’essi ancora colpevolmente inevasi relativi alla riorganizzazione dei trasporti degli studenti secondari, occorreva aprire subito a febbraio dello scorso anno (come si era proposto da più parti) una trattativa sindacale per concordare deroghe non chirurgiche al contratto di lavoro dei docenti. Esso doveva essere reso compatibile con i bisogni concreti delle nuove generazioni nella inedita situazione determinata dalla pandemia. In questo senso, andava subito cambiato il calendario scolastico; aperta una scholé estiva facoltativa per combattere le povertà educative, la dispersione, le carenze di apprendimento personali; introdurre e sperimentare una modalità organizzativa dello stare a scuola che finalmente abbandonasse il modello novecentesco della fabbrica-caserma (classi-plotoni, sezioni-compagnia, scuola-reggimento) con organico dei docenti assegnato dal quartier generale non in base ai problemi dei terreno e delle specificità delle azioni da compiere, ma nel modo astratto tipico di tutte le organizzazioni che chiedono alle persone di adattarsi alle proprie regole costitutive, e non il contrario, come dovrebbe accadere in qualsiasi vera scuola che non proclami, ma pratichi la centralità della persona e della sua formazione integrale.
3) La didattica a distanza, vissuta come una necessità, ora viene messa seriamente in discussione per i suoi effetti perversi in termini pedagogici e anche psichico-relazionali. Lei ha parlato di emergenza pedagogica. Ci spiega che cosa intende?
La colpa è tutta del Ministero. Prima di tutto perché ha equiparato la ricchezza possibile della rivoluzione digitale con la DAD. In secondo luogo, perché ha concepito la DAD come il fare a distanza le cose che non si potevano più fare in presenza (appello, assenze, ore di lezione disciplinari, interrogazioni, compiti in classe e domestici). Fino al ridicolo di prevedere studenti che passano 5 o 6 ore da soli dinanzi al pc in ambienti casalinghi non sempre adatti allo scopo, con interrogazioni condotte in alcuni casi con le bende sugli occhi per impedire il rischio di sbirciare libri o appunti e invocando, per “i compiti in classe”, il proctoring (tecnologia per controllare che gli studenti li facciano davvero da soli). Senza dubbio la soluzione più efficace per uccidere due piccioni, possibili messaggeri di innovazioni attese da vent’anni, con la stessa fava avvelenata: ovvero, da un lato, far credere che la scuola in presenza potesse fare a meno della rivoluzione digitale per offrire il meglio di sé; dall’altro lato, indurre studenti e famiglie a ritenere che la rivoluzione del digitale in didattica si potesse assimilare alla DAD (riduzione a tal punto inaccettabile e insopportabile da spingere gli studenti a reclamare il ritorno alla tradizionale didattica in presenza senza digitale). I giovani e la società italiana pagheranno a lungo gli effetti negativi di questi fraintendimenti.
4) Ci sono modalità per migliorare la didattica a distanza? Quali?
C’è un criterio empirico forse un po’ rozzo, ma molto chiaro per riconoscerle: sapere che ciò che va bene in presenza, non va bene a distanza. E viceversa. Solo l’alleanza tra le due diverse prospettive e i due diversi paradigmi può dare ricchezza cognitiva. In presenza, per esempio, c’è una determinata distanza tra gli studenti e il professore, tra studente e studente (a parte il metro di rima buccale, gli studenti, in aula, possono comunicare tra di loro solo quando lo stabilisce il docente), tra l’esigua porzione di mondo contenuta all’interno dell’aula scolastica e il resto del mondo, che sta oltre la finestra e che coincide con la vita «normale», dalla famiglia alla città all’impresa. Non occorre molto a comprendere che queste distanze, con i loro messaggi impliciti ed espliciti, non valgono e non reggono neanche a volerlo da remoto. E che un remoto impostato nello stesso modo del vicino è solo dannoso. Per chi vuole saperne di più mi permetto rimandare al libro citato in esordio.
Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.